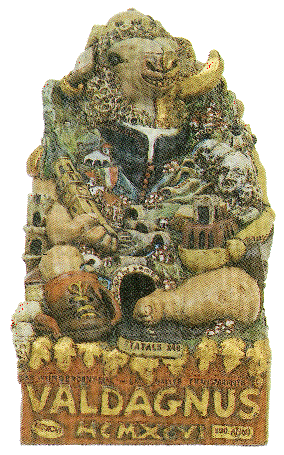 Il mare d'erba
Il mare d'erba
Mi trovo al Loft Club per caso insieme ad un gruppetto di intellettuali valdagnesi a scoprire un mistero chiamato dagli autori Erma Pantheon della Valle dell'Agno. Mi aggiro con le mani in tasca intorno ad un tavolo spoglio sul quale è stato posto questo strano oggetto che nella forma mi ricorda una vecchia poltroncina sdrucita che mia madre aveva nella camera da letto, reliquia del suo scarnissimo corredo con il quale si era maritata.
Mi è stato raccomandato di osservarlo con attenzione e riferire le mie sensazioni. Per quanta buona volontà ci metta, non ci vedo alcunchè di suggestivo tranne quel buffo ricordo di famiglia. Mi sforzo di richiamare alla mente altre associazioni. Indubbiamente mi attraggono i suoi colori vivaci che ricordano le vetuste sculture policrome in legno che ho visto nelle piccole chiese parrocchiali della Bretagna.
Ma cosa altro si aspettano da me questi gentilissimi ospiti? Mi metto a scrutare il silenzioso loro oggetto. Uno strano animale immaginario - con la testa per metà agnello e per metà ariete e con dietro la faccia stolida dello scemo del paese, tale Nani Piove, che troneggia sogghignando. Il richiamo all'agnello, simbolo di questa loro città, mi sembra una allegoria così voluta da apparirmi trita in tutta la sua ingenua banalità. Ho la sensazione di una semplicità troppo palese per essere autentica. Forse gli autori avevano volutamente scelto un linguaggio elementare per entrare in contatto con un più vasto numero di persone ma forse costoro - mi chiedo tra me e me - sono meno artigiani di quanto vogliano apparire, dissimulano, forse sono addirittura artisti che hanno con sofisticata provocazione finto di credere a forme e colori tanto popolareschi? Ma il quesito non è alla mia portata critica, non ho titoli infatti per decidere se mi trovo davanti ad un' opera d'arte o al frutto di un buon artigianato.
Spucio tra le mie nozioni di estetica, polverose reminiscenze dei miei studi liceali e me ne viene uno spunto dalla definizione crociana di essere l'arte una intuizione lirica pura e di qui la curiosità di scoprire quale sia stata per gli autori "l'intuizione", quanto di "lirico" ci sia in loro e se tutto questo sia stato un atto "puro" cioè immediato, istintivo, non pensato. Quesiti impegnativi che subito abbandono.
In effetti, per dirla tutta, da questa cosa mi sento affatto lontano, mi è estranea, va bene - mi dico - c'è, esiste ma non aggiunge nulla al mio patrimonio di esperienze interiori, non tocca alcuna corda mia intima. Sento qualcuno degli invitati tuffato in dotte analisi sociologiche, un altro deluso per il disfacimento della "intellighènzia" valdagnese impossibilitata a darsi una voce e dare una voce al paese reale, un altro che vi vede l'anima grottesca della città, un altro la celebrazione del funerale di una comunità ormai senza futuro. Tutte le opinioni mi paiono condivisibili. Ma è sempre e solo Valdagno l'oggetto delle analisi e ciò aumenta il mio disagio: sono fuori posto qui - mi convinco - la cosa non mi riguarda in niente.
Intanto mi sono anche fisicamente allontanato dagli altri quasi rifugiato dietro alla statua; le sto impalato vicino in un atteggiamento di gentile, ma finto interesse. Ma mentre faccio l'ennesima esplorazione di quella specie di labirinto di ceramica mi accorgo, perbacco, che qualcosa giace da scoprire ancora oltre la patina dei bei colori. Comincio a vedere sotto la testa ovina un corpo, un corpo umano semisdraiato in una specie di trono, la sua parte inferiore certamente di donna: me lo indicano le gambe tornite pur se certo un po' tozze e mollemente allargate sì da richiamare alla mente quella vaga lascivia che avevo tante volte, ragazzo, notato nelle contadine del mio paese, e proprio in mezzo alle gambe, là dove esse si riuniscono, è un foro nero dal quale esce una strada: vuole rappresentare il traforo che collegherà, in un futuro più o meno lontano, Valdagno a Schio ma il richiamo sessuale è chiaro anche se più ingenuo che volgare. Come il traforo negli anni ha alimentato tanti sogni,
tante passion e tante delusioni così quell'antro oscuro tenta con la sua malcelata malizia e prefigura ogni possibile piacere e squallore.
Certamente di "puro", in senso crociano, non vedo nulla in questa rappresentazione però da altri piccoli particolari che man mano riesco a notare oltre all'ironia, al sarcasmo di uno spirito polemico a tratti troppo marcato, colgo una partecipazione: più che l'opera di un notaio che si limita a registrare da fuori la situazione intuisco sempre più l'opera di un appassionato corista che canta questo popolano inno d'amore alla propria città.
Tutto questo mi è ormai abbastanza evidente, ma francamente continua a non coinvolgermi più di tanto perchè non vedo in che modo possa sentirmi rappresentato da questo oggetto. Dopo tutto si rappresenta Valdagno, si celebrano i ricordi più o meno nitidi di generazioni di valligiani, si rievocano i tanti simboli di questa comunità: la dinastia della famiglia più potente, il campanile, la piazza, il quartiere dei servizi sociali, la vecchia cantina, lo scemo del paese, e tutto un minuscolo esercito di personaggi passati nella cronaca di questa cittadina, che mi ha accolto con simpatia tanti anni fa e nella quale io e la mia famiglia ci siamo integrati senza sforzo.
E' proprio una bella, completa, armonica rappresentazione di Valdagno - mi animo - tanto che sembra quasi che si possano percepire i suoi rumori come li avevo percepiti io al mio arrivo qui, gli umori della sua gente, perfino i suoi odori che esalavano dalle stradine strette, dai vicoli umidi, ma non squallidi e mai sporchi, abbelliti sempre da qualche pianta di gerani che occhieggiava dalle piccole finestre. Ed i colori. Così particolari, così diversi da quelli che ero abituato a vedere al mio paese, eppure ugualmente belli. Certo niente potrà mai darmi le stesse emozioni che guardare il blu della marina dall'alto di una scogliera, il mare brillare lontano come una immensa distesa di pagliuzze d'oro, i cieli tersi di albe meravigliose, il profumo inebriante dei prati di origano in fiore, che si diffondeva per miglia nella campagna deserta, i silenzi assoluti rotti soltanto dallo sciacquio delle onde sugli scogli.
Eppure, eppure all'improvviso riaffiorano alla mente le immagini di quelle enormi distese di verde della primavera inoltrata che tanto mi avevano colpito la prima volta che andai verso Castelvecchio; quel mare d'erba, che non era meno bello dell'azzurro del mio mare, ed i fiori: coloratissimi, tenui, discreti, sfolgoranti, grandi, piccoli, resistenti, gracili, a migliaia arrivati per rallegrare tutto intorno. E' quasi un dispetto della memoria ricordare allora anche un'altra grande emozione vissuta qualche mese dopo il mio arrivo. Una mattina di buon'ora mi affacciai al balcone perchè avevo intravvisto finalmente un raggio di sole filtrare attraverso le persiane dopo interminabili giornate di pioggia. Il cielo era limpidissimo, come di cristallo, di un azzurro intenso e di fronte c'erano le colline dello Zovo rigogliose di alberi. I colori del bosco erano quella mattina assolutamente unici, così belli da sembrare irreali; andavano dal verde cupo al verde chiaro al marrone al
rosso al giallo tutti insieme in uno stupendo affresco. Non avevo mai visto nulla di simile e ringraziai Dio di avermene dato l'opportunità.
Ed allora ecco che mi metto a guardare questa statua con occhi diversi, più attenti, più partecipi, più affettuosi. E mi stupisco allora di quanto, senza che me ne fossi accorto in tutti questi anni, io abbia assorbito questi posti, questa gente, di quanto mi sia permeato delle loro abitudini, di quanto mi sia arricchito di esperienze e di affetti. E d'improvviso tutto mi appare familiare, caro. Il richiamo alla mia terra non è affatto stridente: riesco a far convivere tranquillamente i temporali violenti e gli inattesi arcobaleni della mia infanzia con la pioggerellina fitta e un po' triste di queste colline e con i loro meravigliosi squarci d'azzurro; il blu del mare somiglia al verde delle colline ed in comune hanno ininterrotti silenzi d'incanto. E poi quando il mio sguardo incontra il faccione di Nani Piove improvvisamente mi torna in mente Felice, lo scemo del mio paese natale, laggiù in Lucania, una terra del Sud della quale non tutti qui conoscono l'esistenza.
Felice era un personaggio unico, sempre coperto da un cappotto liso e lucido di sporco, che indossava sia d'inverno che d'estate. Era un barbone senza età come tanti: nessuno può dire quanti anni abbia un barbone. Era sempre sfuggente eppure sempre in mezzo a noi ragazzi, sempre agitato e innocuamente minaccioso sia che lo prendessimo in giro sia che lo ignorassimo. Quando un giorno scomparve senza lasciare alcuna traccia, sentimmo molte congetture tra i grandi ma a noi ragazzini, che improvvisamente ci accorgevamo di quanto ci fossimo legati a lui, piaceva dar credito ad un'altra voce che lo voleva partito per l'America, richiamato da un suo lontano parente diventato laggiù molto ricco e potente.
Ecco! Nani Piove mi ricorda che quest'opera appartiene un po' anche a me. Ed un'onda impetuosa quanto dolce di ricordi mi sottolinea tutte le analogie che man mano mi si parano davanti: il campanile della chiesetta dove avevo imparato le prime preghiere, la piazzetta che risonava d'estate fino a sera delle voci dei bambini, la cantina che nella buona stagione aveva all'esterno due nudi tavoloni di legno, il muretto dove sedevano i vecchietti che si raccontavano le loro interminabili, bellissime storie, la fontana che proiettava i suoi gioiosi zampilli contro il cielo sempre sereno, Ormai guardo ad occhi chiusi tutta quella schiera interminabile di volti che avanza verso di me: il vecchio parroco, burbero e paziente, con quel suo inconfondibile odore che chiamavamo di sacrestia, il nobile del paese, che vedevamo solo la domenica a Messa circondato dalla sua famiglia e che si degnava di rispondere con sussiego al saluto devoto di mio nonno, suo massaro, che si toglieva il cappello
appena lo vedeva uscire dl palazzotto, la padrona del bar, l'anziano salumiere, che mi dava sempre una caramella in più rispetto a quelle che le mie cinque lire mi potevano pagare.
Com'è possibile che luoghi così distanti tra loro, situazioni così lontane nel tempo, fatti così singolari si somiglino tanto? Sembra un miracolo eppure quella statua raffigura il mio paese, ne sono ormai certo. Come l'autore abbia potuto conoscere i luoghi della mia infanzia e per quale miracolo sia riuscito a raffigurarli con tanta precisione non lo so, non mi interessa.
Finalmente ho come per incanto capito: Valdagno è stata solo un pretesto. In quella composita rappresentazione sacra e pagana, popolana ed intellettuale, ingenua e sofisticata, in quell'inferno dantesco rovesciato c'è il rispettoso appello a tutte le comunità del mondo piccole grandi del nord del sud di montagna e di mare calde e fredde, c'è un atto d'amore sì per la propria terra ma di più l'intento di richiamare alla memoria di ognuno qualsiasi comunità attraverso i suoi simboli più tradizionali nelle sue virtù, nelle sue meschinità, nei suoi slanci generosi, nelle sue miserie, un omaggio al ricordo dolce e struggente di ognuno per le sue origini, per la sua gente. E la gente è uguale in tutte le parti del mondo.
Ora sono certo di essere rappresentato in quest'opera. Non mi era mai capitato di sentirmi tra questa gente solo ed isolato, ma un po' "foresto" sì ed ora mi si matura dentro addirittura un rivolgimento straordinario: vedo solo le affinità che legano i due posti, entrambi li amo e, grazie a Dio, non ho più l'incubo di dover rinunciare alle mie radici. Ho capito che non ce n'era alcun bisogno: troppe sono le somiglianze, tanto insignificanti le diversità.
Non ho ancora risolto il dubbio se la statua sia opera di un artigiano o di un artista e francamente mi sembra una sterile esercitazione su questo oggetto indigeno che argutamente ha dato un suo piccolo contributo per aiutarmi a leggermi dentro.
E non è merito da poco.
 Florilegio di scritti di varia umanita' Indice
Florilegio di scritti di varia umanita' Indice